
Nella Francia del secondo dopoguerra, la vita letteraria ritrova le sue istituzioni e i suoi riti, ma il tessuto del Paese è ancora lacerato dalla ferita profonda che il maresciallo Pétain ha inferto ai francesi col suo regime collaborazionista di Vichy. Si cercano capri espiatori, veri o presunti, come per cancellare nel più breve tempo possibile una macchia che dovrà invece durare per molto tempo. Louis Ferdinand Céline è un bersaglio ideale: il suo atteggiamento favorevole al Nazismo, rafforzato dai suoi libelli antisemiti e dall’aura di maledetto che lo avvolge, hanno plasmato un mostro da non sbattere in prima pagina, ma da tenere ai margini e relegare all’oblio. Contro questa condanna alla morte civile, Céline decide di reagire scrivendo Colloqui col Professor Y, e lo fa servendosi di uno strumento banale, quotidiano (talvolta anche noioso, bisogna dirlo): un’intervista letteraria che dovrebbe reinserirlo nel flusso dei media. Ma l’intervista è ambientata in un palcoscenico sul quale l’autore mette in scena un se stesso torrentizio, un Céline al quadrato che nella metamorfosi teatrale diventa maschera e parodia dell’originale; quanto all’intervistatore, è una creatura tanto inventata quanto improbabile; perfino la sua identità è posticcia e provvisoria: all’inizio è quella di un sedicente professor Y, meschino, supponente, arrivista, piccoloborghese, che successivamente si rivelerà per un ancor meno credibile Colonnello Réseda. Cos’ha a che vedere un Colonnello con la letteratura? Niente, e sembra proprio che Céline si costruisca questo interlocutore tanto estraneo e malevolo per usarlo come un punging ball mentre ricostruisce le tecniche dei suoi romanzi, distrugge gli autori patacca, si scaglia contro il sistema mediatico. Ma come ogni burattinaio finisce per essere dipendente dalla sua marionetta, così Céline si lascia trascinare dal suo Professore/Colonnello in un assurdo crescendo che travalica i confini della letteratura per giungere al comico asciutto e totale del teatro.
A.G.


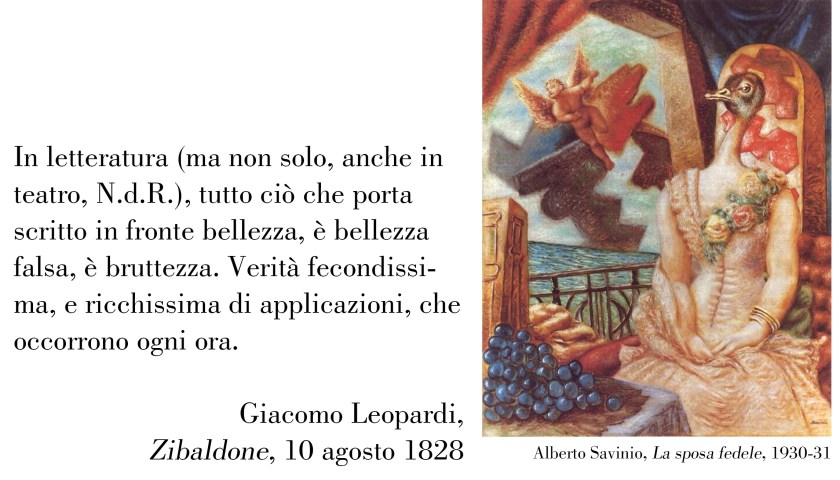














 A cena, dopo la replica di ieri: “Lo spettacolo è divertente, raffinato (seguono svariati altri apprezzamenti, N.d.R.), ma valeva la pena profondere tanto impegno (bravi attori, ecc.) su testi così fragili?”. La domanda non è affatto peregrina e come risposta meriterebbe un seminario. Non tanto sulla qualità di questi sketch di Fellini, quanto sull’atteggiamento, direi preliminare, dell’autore che affronta la scrittura di un testo destinato a una diffusione mediatica. Negli anni Quaranta, la radio era un mezzo di diffusione straordinario (con venature magiche: le misteriose onde sonore che viaggiavano nell’etere) e al tempo stesso potenzialmente (e pericolosamente) vicino a una massa di utenti “nuovi” e non acculturati. Scrivere per la radio significava scrivere per una platea indistinta è tendenzialmente ignorante, affatto diverso da quella “alta” del teatro. Era un atteggiamento duro a morire, se ancora negli anni Sessanta un onnipotente direttore generale della rai poteva affermare: “I telespettatori sono trenta milioni di teste di cazzo” – sembra che l’affermazione fosse in realtà un’invenzione giornalistica, ma rappresentava comunque un pensiero oscillante fra l’altezzoso e il paternalistico che aleggiava ai piani alti di Viale Mazzini. Per tornare agli sketch, mi piacerebbe sapere con quale animo il giovane Fellini affrontasse il suo impegno di autore radiofonico; purtroppo non ne ho gli strumenti, ma certamente lavorava in fretta e superficialmente. Mi sento di dirlo ripensando alla mia esperienza di autore radiofonico: molto spesso mi sono trovato nella condizione di dover scrivere, per ragioni di produzione, uno sceneggiato di trenta minuti (compresa l’ideazione del soggetto) dalla mattina alla sera. Non parlerei di scrittura industriale, ma piuttosto di scrittura in stato automatico; si lavora entro le strutture consolidate di un genere e si deve far fluire la scrittura; come il fiume trascina di tutto, dai copertoni ai cadaveri, ai tronchi di legno pregiato, così la sceneggiatura lampo rimette in gioco, e disordinatamente, le tue letture (adulte e dell’infanzia), le suggestioni dei quotidiani che hai appena letto, e un certo buon senso comune che magari non condividi ma che utilizzi come strumento di dialogo con un pubblico “popolare”. Mi rendo conto che questo ritratto dell’autore radiofonico finisce per raffigurare un personaggio opportunista, un po’ cinico, superficiale e sostanzialmente senza scrupoli: un puzzle di tanti disvalori, insomma. Ma direi che proprio qui sta il bello del gioco. Del gioco del teatro, dico, e in particolare del nostro spettacolo, che va a rovistare nel grigio magazzino dei copioni radiofonici per riportarne alla luce una dozzina e mostrandoli nella loro disarmata nudità. Ne risulta, credo, un’oscenità civettuola, che nulla promette a parole e forse qualche cosa dà, sottobanco (grazie alla bravura degli attori, a un montaggio impassibile, ecc. ecc.)
A cena, dopo la replica di ieri: “Lo spettacolo è divertente, raffinato (seguono svariati altri apprezzamenti, N.d.R.), ma valeva la pena profondere tanto impegno (bravi attori, ecc.) su testi così fragili?”. La domanda non è affatto peregrina e come risposta meriterebbe un seminario. Non tanto sulla qualità di questi sketch di Fellini, quanto sull’atteggiamento, direi preliminare, dell’autore che affronta la scrittura di un testo destinato a una diffusione mediatica. Negli anni Quaranta, la radio era un mezzo di diffusione straordinario (con venature magiche: le misteriose onde sonore che viaggiavano nell’etere) e al tempo stesso potenzialmente (e pericolosamente) vicino a una massa di utenti “nuovi” e non acculturati. Scrivere per la radio significava scrivere per una platea indistinta è tendenzialmente ignorante, affatto diverso da quella “alta” del teatro. Era un atteggiamento duro a morire, se ancora negli anni Sessanta un onnipotente direttore generale della rai poteva affermare: “I telespettatori sono trenta milioni di teste di cazzo” – sembra che l’affermazione fosse in realtà un’invenzione giornalistica, ma rappresentava comunque un pensiero oscillante fra l’altezzoso e il paternalistico che aleggiava ai piani alti di Viale Mazzini. Per tornare agli sketch, mi piacerebbe sapere con quale animo il giovane Fellini affrontasse il suo impegno di autore radiofonico; purtroppo non ne ho gli strumenti, ma certamente lavorava in fretta e superficialmente. Mi sento di dirlo ripensando alla mia esperienza di autore radiofonico: molto spesso mi sono trovato nella condizione di dover scrivere, per ragioni di produzione, uno sceneggiato di trenta minuti (compresa l’ideazione del soggetto) dalla mattina alla sera. Non parlerei di scrittura industriale, ma piuttosto di scrittura in stato automatico; si lavora entro le strutture consolidate di un genere e si deve far fluire la scrittura; come il fiume trascina di tutto, dai copertoni ai cadaveri, ai tronchi di legno pregiato, così la sceneggiatura lampo rimette in gioco, e disordinatamente, le tue letture (adulte e dell’infanzia), le suggestioni dei quotidiani che hai appena letto, e un certo buon senso comune che magari non condividi ma che utilizzi come strumento di dialogo con un pubblico “popolare”. Mi rendo conto che questo ritratto dell’autore radiofonico finisce per raffigurare un personaggio opportunista, un po’ cinico, superficiale e sostanzialmente senza scrupoli: un puzzle di tanti disvalori, insomma. Ma direi che proprio qui sta il bello del gioco. Del gioco del teatro, dico, e in particolare del nostro spettacolo, che va a rovistare nel grigio magazzino dei copioni radiofonici per riportarne alla luce una dozzina e mostrandoli nella loro disarmata nudità. Ne risulta, credo, un’oscenità civettuola, che nulla promette a parole e forse qualche cosa dà, sottobanco (grazie alla bravura degli attori, a un montaggio impassibile, ecc. ecc.)