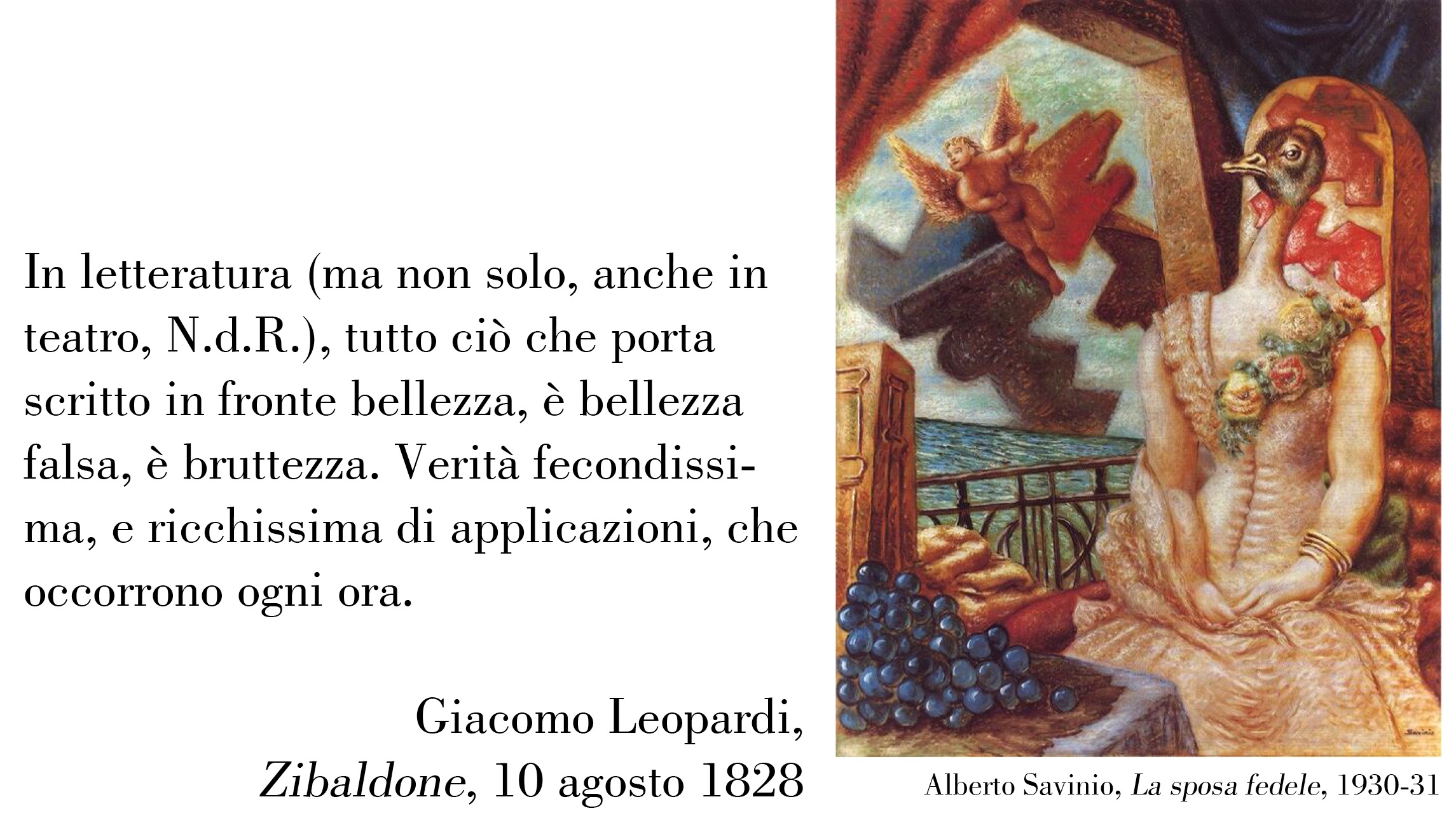Nella Francia del secondo dopoguerra, la vita letteraria ritrova le sue istituzioni e i suoi riti, ma il tessuto del Paese è ancora lacerato dalla ferita profonda che il maresciallo Pétain ha inferto ai francesi col suo regime collaborazionista di Vichy. Si cercano capri espiatori, veri o presunti, come per cancellare nel più breve tempo possibile una macchia che dovrà invece durare per molto tempo. Louis Ferdinand Céline è un bersaglio ideale: il suo atteggiamento favorevole al Nazismo, rafforzato dai suoi libelli antisemiti e dall’aura di maledetto che lo avvolge, hanno plasmato un mostro da non sbattere in prima pagina, ma da tenere ai margini e relegare all’oblio. Contro questa condanna alla morte civile, Céline decide di reagire scrivendo Colloqui col Professor Y, e lo fa servendosi di uno strumento banale, quotidiano (talvolta anche noioso, bisogna dirlo): un’intervista letteraria che dovrebbe reinserirlo nel flusso dei media. Ma l’intervista è ambientata in un palcoscenico sul quale l’autore mette in scena un se stesso torrentizio, un Céline al quadrato che nella metamorfosi teatrale diventa maschera e parodia dell’originale; quanto all’intervistatore, è una creatura tanto inventata quanto improbabile; perfino la sua identità è posticcia e provvisoria: all’inizio è quella di un sedicente professor Y, meschino, supponente, arrivista, piccoloborghese, che successivamente si rivelerà per un ancor meno credibile Colonnello Réseda. Cos’ha a che vedere un Colonnello con la letteratura? Niente, e sembra proprio che Céline si costruisca questo interlocutore tanto estraneo e malevolo per usarlo come un punging ball mentre ricostruisce le tecniche dei suoi romanzi, distrugge gli autori patacca, si scaglia contro il sistema mediatico. Ma come ogni burattinaio finisce per essere dipendente dalla sua marionetta, così Céline si lascia trascinare dal suo Professore/Colonnello in un assurdo crescendo che travalica i confini della letteratura per giungere al comico asciutto e totale del teatro.
A.G.