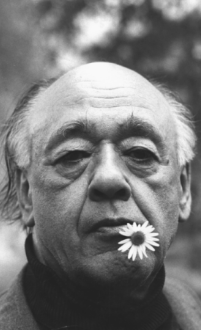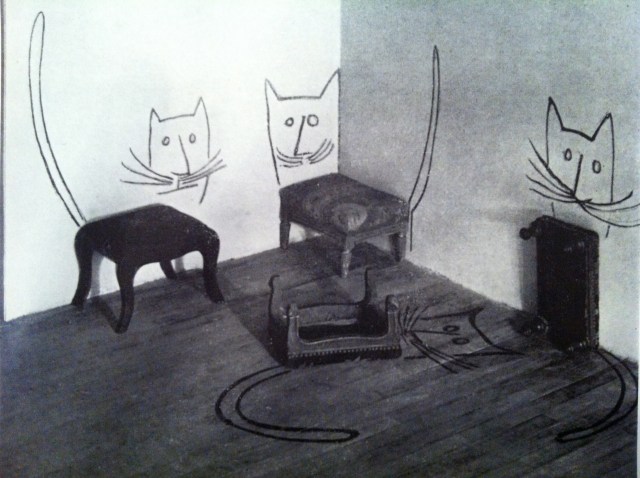L’ultima volta che ho visto mio padre è stato alla Grand Central Station. Stavo andando da mia nonna sui Monti Adirondack, in una villetta sul Capo che mia madre aveva affittato, e avevo scritto a mio padre che sarei rimasto a New York, tra un treno e l’altro, per un’ora e mezza; gli avevo chiesto se potevamo pranzare insieme. La sua segretaria mi aveva risposto che lui mi avrebbe aspettato all’ufficio informazioni a mezzogiorno, e alle dodici spaccate lo vidi arrivare facendosi largo tra la folla. Per me era un estraneo: mia madre aveva divorziato tre anni prima, e da allora non ero più stato con lui. Ma appena lo vidi capii che era mio padre, carne della mia carne, sangue del mio sangue, il mio futuro e il mio destino. Sapevo che una volta cresciuto avrei somigliato a lui, in qualche modo; avrei dovuto progettare le mie campagne entro i limiti che lui mi avrebbe posto. Era un uomo grande e grosso e di bell’aspetto, e io ero tremendamente contento di rivederlo. «Ciao, Charlie», disse. «Ciao, ragazzo. Mi piacerebbe portarti al mio club, ma è oltre la Sessantesima, e se devi prendere un treno il pomeriggio presto credo che faremo meglio a mangiare qualche cosa qui vicino.» Mi mise un braccio sulle spalle e io annusai mio padre come mia madre annusa una rosa. Era un forte miscuglio di whiskey, di dopobarba, di lucido da scarpe, di indumenti di lana, con l’odore acre di un maschio maturo. Sperai che qualcuno ci vedesse insieme. Desiderai che qualcuno ci fotografasse. Volevo un ricordo del nostro incontro. Uscimmo dalla stazione e andammo in un ristorante in una strada laterale. Era ancora presto e il locale era vuoto. Il barista stava litigando con un fattorino, e vicino alla porta della cucina c’era un cameriere molto vecchio con una giacca rossa. Ci sedemmo, e mio padre chiamò il cameriere ad alta voce. «Kellner!» gridò. «Garçon! Cameriere! Ehi tu!» La sua arroganza nel ristorante vuoto sembrò fuori posto. «Si può venire serviti qui?» gridò. «Gnam gnam.» Poi batté le mani. Quel gesto attirò l’attenzione del cameriere, che arrivò al nostro tavolo strascicando i piedi. «Batteva le mani a me?» chiese. «Si calmi, si calmi, sommelier», disse mio padre. «Se non è troppo chiederglielo, se questo non significa offendere le sue prerogative, gradiremmo due Gibson con Beefeater» «Non mi piace che mi chiamino battendo le mani», disse il cameriere. «Avrei dovuto portare il mio fischietto», disse mio padre. «Ho un fischietto che può venire udito solo dalle orecchie dei vecchi camerieri. Adesso tiri fuori il blocchettino e la matitina e vediamo se riesce a scrivere giusto: due Gibson con Beefeater Ripeta con me: due Gibson con Beefeater.» «Credo che fareste meglio ad andare da qualche altra parte», disse tranquillamente il cameriere. «Questo», disse mio padre, «è uno dei consigli migliori che abbia mai ricevuto. Vieni, Charlie, andiamocene di qui, diavolo.» Seguii mio padre fuori dal ristorante e dentro un altro. Questa volta non fu tanto arrogante. I nostri drink arrivarono, e lui mi fece un sacco di domande sul campionato di baseball. Poi colpì con il coltello l’orlo del bicchiere vuoto e ricominciò a gridare. «Garçon! Kellner! Ehi tu! Portacene altri due uguali, se non è di troppo disturbo.» «Quanti anni ha il ragazzo?» chiese il cameriere. «Questo», rispose mio padre, «non è affar tuo, accidenti.» «Mi dispiace, signore», replicò il cameriere, «ma non servirò un altro drink al ragazzo.» «Be’, devo darti una notizia», disse mio padre. «Una notizia proprio interessante. Succede che questo non è l’unico ristorante di New York. Ne hanno aperto un altro proprio all’angolo. Vieni, Charlie.»
Pagò il conto e lo seguii fuori dal ristorante e dentro un altro. Qui i camerieri avevano della giacche scarlatte come quelle dei cacciatori, e sulle pareti c’era un sacco di finimenti. Ci sedemmo e mio padre ricominciò a urlare. «Maestro di caccia»! Dalli dalli con tutto quel che segue. Vorremmo qualcosina da bere, sotto forma di un bicchiere della staffa. «Precisamente. Due Bibson con Geefeater.» «Due Bibson con Geefeater?» chiese sorridendo il cameriere. «Ha capito perfettamente bene quello che voglio», disse irosamente mio padre «Voglio due Gibson con Beefeater, e subito. Sono cambiate le cose, nella vecchia e allegra Inghilterra. Così mi ha detto il mio amico, il duca. Vediamo che cosa può produrre l’Inghilterra nel campo dei cocktail.» «Qui non siamo in Inghilterra», osservò il cameriere. «Non discuta con me», disse mio padre. «Faccia solo quello che le è stato detto.» «Pensavo solo che avrebbe gradito sapere dove si trova», disse il cameriere. «Se c’è una cosa che non posso sopportare», osservò mio padre, «è un cameriere impertinente. Vieni, Charlie.» Il quarto posto dove andammo era italiano. «Buon giorno», disse mio padre. «Per favore, possiamo avere due cocktail americani, forti, forti. Molto gin, poco vermut. » «Non capisco l’italiano», disse il cameriere. «Oh, la pianti», disse mio padre. «Lei capisce l’italiano, e sa perfettamente bene di capirlo. Vogliamo due cocktail americani. Subito.» Il cameriere se ne andò a parlare con il capocameriere, che venne al nostro tavolo e disse: «Mi dispiace, signore, ma questo tavolo è riservato». «Va bene», disse mio padre. «Ce ne dia un altro.» «Tutti i tavoli sono riservati», disse il capocameriere. «Ho capito», disse mio padre. «Non desiderate averci come clienti. E’ così? Be’, al diavolo. Vada all’inferno. Andiamo, Charlie.» «Devo prendere il treno», dissi. «Mi dispiace, figliolo», disse mio padre. «Mi dispiace moltissimo » Mi mise un braccio sulle spalle e mi strinse contro di sé. «Ti riaccompagno in stazione. Se solo ci fosse stato il tempo di andare al mio club.» «Fa lo stesso, papà», dissi. «Ti comprerò un giornale», disse. «Ti comprerò un giornale da leggere in treno.» Poi si avvicinò a un’edicola e chiese: «Gentile signore, sarebbe tanto cortese da favorirmi uno dei vostri maledetti giornali del pomeriggio da dieci cent che non valgono niente?» Il giornalaio si girò dall’altra parte e fissò la copertina di una rivista. «E’ troppo, gentile signore», disse mio padre, «è troppo se le chiedo di vendermi uno dei suoi disgustosi esemplari di giornalismo scandalistico?» «Devo andare, papà», dissi. «E’ tardi.» «Su, aspetta un momento, figliolo», disse. «Aspetta solo un momento. Voglio stuzzicare un po’ questo tizio.» «Arrivederci, papà», dissi. Scesi le scale e presi il treno, e quella fu l’ultima volta che vidi mio padre.
John Cheever, Incontro, “Narratori di poche parole, Guanda. Traduzione Luigi Schenoni
 https://vimeo.com/108898457
https://vimeo.com/108898457