
https://www.youtube.com/watch?v=ejNVSjeIr9E
Il primo miracolo l’aveva compiuto la tecnologia che aveva imprigionato le immagini in una scatola – anzi in pochissime, molto costose, che solo certi nuovi ricchi possedevano, quelli più stagionati e blasonati se ne guardavano: “mettersi il mondo in casa” era una frase a effetto, ma poi non si sapeva chi sarebbe entrato (un casino, insomma, anche se allora non ci si esprimeva così), quindi il mondo poteva starsene dov’era sempre stato, e quando uno aveva voglia di incontrarlo bastava che prendesse l’automobile e andasse a farci un giro.
Nel 1954, la televisione italiana incominciò la sua colonizzazione. I rari televisori, nelle vetrine dei negozi di elettrodomestici o In qualche abitazione di un pioniere facoltoso, radunavano folle considerevoli di passanti e di condomini, nonché di inquilini poveri ma giudicati meritevoli che si allineavano in piedi lungo le pareti dei soggiorni manifestando una controllata euforia per quell’imprevisto lampo di socialismo umanitario.
Il secondo miracolo lo fecero i mondiali di calcio, nello stesso anno. I poveri (ancora loro) e la piccola borghesia (che riusciva ad arraffare qualche sediola) facevano mentalmente i calcoli di quanto sarebbe costato l’ingresso in uno stadio svizzero, e ringraziavano i padroni di casa, il Progresso, forse anche il buon Dio, per quel dono che veniva recapitato gratuitamente a domicilio attraverso l’etere, che qualcosa col buon Dio doveva aver pure a che fare.
Il terzo miracolo lo fece la squadra della Germania Ovest che batté in finale l’Ungheria per tre a due. La faccenda non era priva di complesse striature emotive e ideologiche: i tedeschi erano il baluardo dell’Occidente contro il comunismo, ma la guerra, terminata da nove anni (un battito di ciglia) aveva lasciato molti strascichi; si scrutavano i turisti che sull’Adriatico venivano a ingurgitare pesciolini fritti e di vinello frizzante chiedendosi quanti anni avesse nel 1945 quel signore grasso e cotto dal sole; nell’incertezza si ricorreva alla fisiognomica e si finiva per dire che aveva una faccia da SS.
L’Ungheria era fortemente legata all’Unione sovietica ma la sua nazionale era composta da artisti del pallone, e per gli anticomunisti si trattava di un ma importantissimo perché pareva loro che quei calciatori funamboli (Puskas, Kocsis, Hidegkuti e tutti gli altri) rappresentassero una protesta vivente, forse un antidoto al totalitarismo; per di più, durante il Fascismo c’era stata una forte circolazione di autori ungheresi melanconici e vellutati che avevano alimentato i sogni delle giovinette e i rimpianti delle loro madri.
Doveva dunque vincere l’Ungheria, cioè la fantasia magiara contro l’ottusa possanza atletica dei crucchi, l’estro contro lo schema, il violino tzigano contro l’organo di Barberia.
Non andò così, e questo fu il terzo e doloroso miracolo. La Germania Ovest vinse rocambolescamente e crudelmente; molti dissero poi che la vittoria fu rubata, pilotata e anche drogata, ma le ricostruzioni e le accuse non poterono rimettere sul piedistallo la squadra che traeva la sua invincibilità dalla bellezza. Quella tranche di mondo che era “entrata nelle case” aveva distrutto un mito celebrato dalla letteratura giornalistica (chi aveva mai visto una partita dell’Ungheria, prima di quelle dirette televisive?). Fu un piccolo dramma sentimentale collettivo. Due anni dopo, nel 1956, un dramma di altra portata si sarebbe consumato a Budapest..











 Un piccolo contributo iconografico al dibattito Pietrangelo Buttafuoco/Gad Lerner, che sul suo blog scrive: “Sostenere che l’ultrà fermano Amedeo Mancini non abbia nulla a che fare con la matrice culturale del fascismo italiano, è davvero un argomento dalle gambe corte. Dice Buttafuoco che i fascisti d’antan, uomini d’onore, mai avrebbero usato l’espressione ‘scimmietta’ all’indirizzo di una donna africana; e a tal fine gli contrappone la presunta nobiltà di una canzone coloniale come ‘Faccetta nera, bella abissina’.”
Un piccolo contributo iconografico al dibattito Pietrangelo Buttafuoco/Gad Lerner, che sul suo blog scrive: “Sostenere che l’ultrà fermano Amedeo Mancini non abbia nulla a che fare con la matrice culturale del fascismo italiano, è davvero un argomento dalle gambe corte. Dice Buttafuoco che i fascisti d’antan, uomini d’onore, mai avrebbero usato l’espressione ‘scimmietta’ all’indirizzo di una donna africana; e a tal fine gli contrappone la presunta nobiltà di una canzone coloniale come ‘Faccetta nera, bella abissina’.”
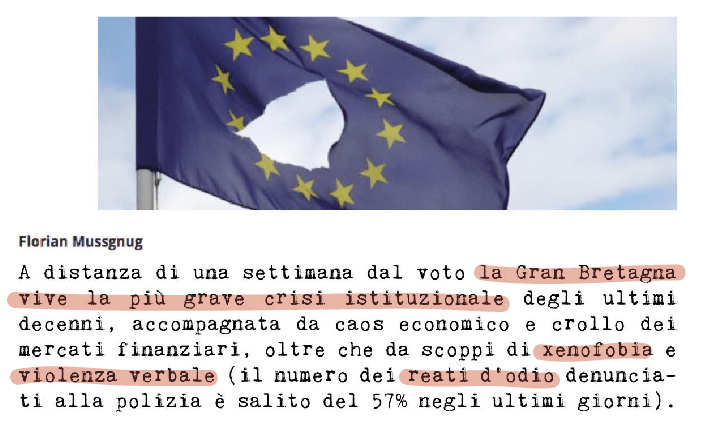
 http://www.repubblica.it/cultura/2016/07/05/news/e_morto_valentino_zeichen-143483853/
http://www.repubblica.it/cultura/2016/07/05/news/e_morto_valentino_zeichen-143483853/