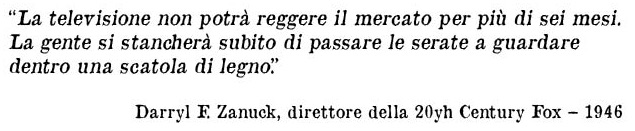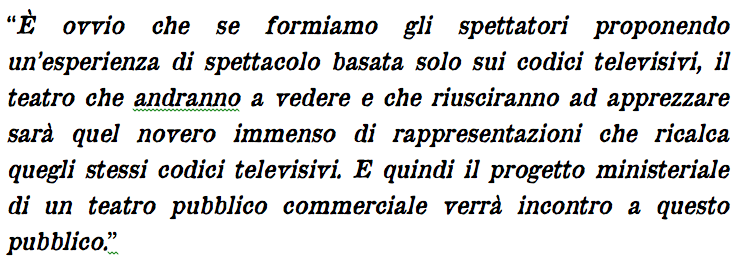Christian La Rosa, Ilaria Matilde Vigna, Elio D’Alessandro, Giorgia Cipolla,
diretti da Leonardo Lidi, in Segretaria
La scatola è linda e razionale: una sala con due ordini di colonne intorno alla quale una gigantesca mano ha avvolto un nastro adesivo; quando sono entrato ho pensato a una sala citata, virgolettata che mi ha fatto pensare alle prime opere di Giulio Paolini, e non a caso, visto che proprio negli anni Settanta in quello stesso spazio, interno al Teatro Gobetti di Torino, ci si ritrovava, con Paolini, appunto, e altri pittori, altri teatranti, altri artistici e vaghi temperamenti. Ci si ritrovava a progettare anche teatro. Qualche risultato talvolta ne usciva; per esempio, nel 1970, Gianfranco De Bosio, all’epoca direttore e regista del Teatro Stabile di Torino, mise in scena alcuni atti unici di autori del Gruppo 63, che era ancora abbastanza fresco. Per molti anni quello spazio si è chiamato, con minimale clarté sabauda, Sala delle Colonne. Oggi si chiama Sala Pasolini: una piccola platea con un praticabile direi di quattro metri per tre, non di più, sul quale recitano quattro attori. Sulla destra, tre strumentisti.
Si mette in scena, con cadenza settimanale, un trittico di Natalia Ginzburg prodotto dal Teatro Stabile di Torino: Dialogo, Segretaria e il più noto Ti ho sposato per allegria.
(Che fatica impelagarsi in una cronaca teatrale: prima di arrivare al dunque bisogna passare per le plaghe grigiastre di queste informazioni, oltretutto con la consapevolezza che sono sempre insufficienti. Mai più!).
Ho visto i primi due spettacoli. Non essendo un recensore all’antica (anzi, non essendolo affatto), non mi ero premurato di leggere in precedenza i testi, che non conoscevo. Ed è stato un bene perché durante l’esecuzione mi sono trovato a compiere istintivamente un’intensa attività comparativa: leggevo la scrittura scenica e nello stesso tempo ricostruivo quella (letteraria, si sarebbe detto un tempo) della Ginzburg. Di solito ricorro a questo impegnativo lavorio per non soccombere di fronte alle più dozzinali messe in scena dei classici; quando mi sento proprio annegare, faccio come gli imbianchini che scrostano le pareti per tornare “a muro” e rifare l’intonaco. Ma durante i due spettacoli che ho visto, il mio andirivieni fra azione scenica e testo non era dettato dalla necessità di sopravvivere; nasceva invece dal piacere di scoprire un progetto drammaturgico che si lasciava leggere in trasparenza mentre prendeva forma sulla scena. Questo dovrebbe essere un pre-requisito, s’intende, ma tutti sappiamo che raramente è così.
Qui, nel progetto Ginzburg, mi sembra che il lavoro sulla drammaturgia del testo e quella scenica si siano svolte in contemporanea, anche se il regista, nel primo spettacolo, Dialogo, ha fatto una scelta molto netta e ricca di conseguenze: ha creato un doppio del marito e della moglie dialoganti. Sulle prime mi è sembrato un rischio: il doppio, in teatro, così carico di suggestioni storiche e teoriche, è un artificio difficile da gestire: spesso questi doppi diventano ingombranti contenitori delle buone intenzioni di partenza. A meno che non si abbiano le idee chiare, come in questo caso. La coppia borghese del testo originario, trasformata in quartetto, consente al regista una concertazione dinamica e liberissima, nella quale il flusso della parola s’incanala e si trasforma creando via via forme di coro, di contrappunto, di basso continuo. Grazie a questa radicale riscrittura scenica, decadono gli psicologismi, e con essi i vezzi e la paccottiglia delle intonazioni di maniera. La crisi della coppia borghese, così omogenea alla poetica della Ginzburg, viene sottratta alla rivisitazione d’epoca (solo qualche sobrio intervento musicale dal vivo crea una straniante profondità storica), per planare nell’oggi, fresca di una crudeltà croccante e nuova.
Lo stesso rigore, declinato in forme diverse impronta anche il secondo spettacolo, Segretaria, imperniato sul perturbante, una ragazza piovuta dal cielo (o rotolata giù da un talamo: dal punto di vista attanziale non c’è troppa differenza), che funge da cartina di tornasole in un malandato (ancora) contesto familiare. Qui i dialoghi eleganti della Ginzburg vengono, per così dire, centrifugati dalla regia e dalla virtuosistica interpretazione degli attori, in un ritmo scenico che senza dubbio non coincide con le scansioni morbide della scrittura letteraria. E viene da dire, fortunatamente, per l’autrice e per noi, perché il migliore recupero dei classici (compresi quelli del Novecento), è proprio quello di usarli, soprattutto se la riscrittura scenica risulta così vitale e motivata come in questo felicissimo trittico.
Teatro Stabile di Torino. QUALCUNO CHE TACE. IL TEATRO DI NATALIA GINZBURG. Teatro Gobetti, Sala Pasolini
Giorgia Cipolla, Elio D’Alessandro, Christian La Rosa e Ilaria Matilde Vigna
Musiche originali eseguite dal vivo dai Perturbazione
Regia di Leonardo Lidi