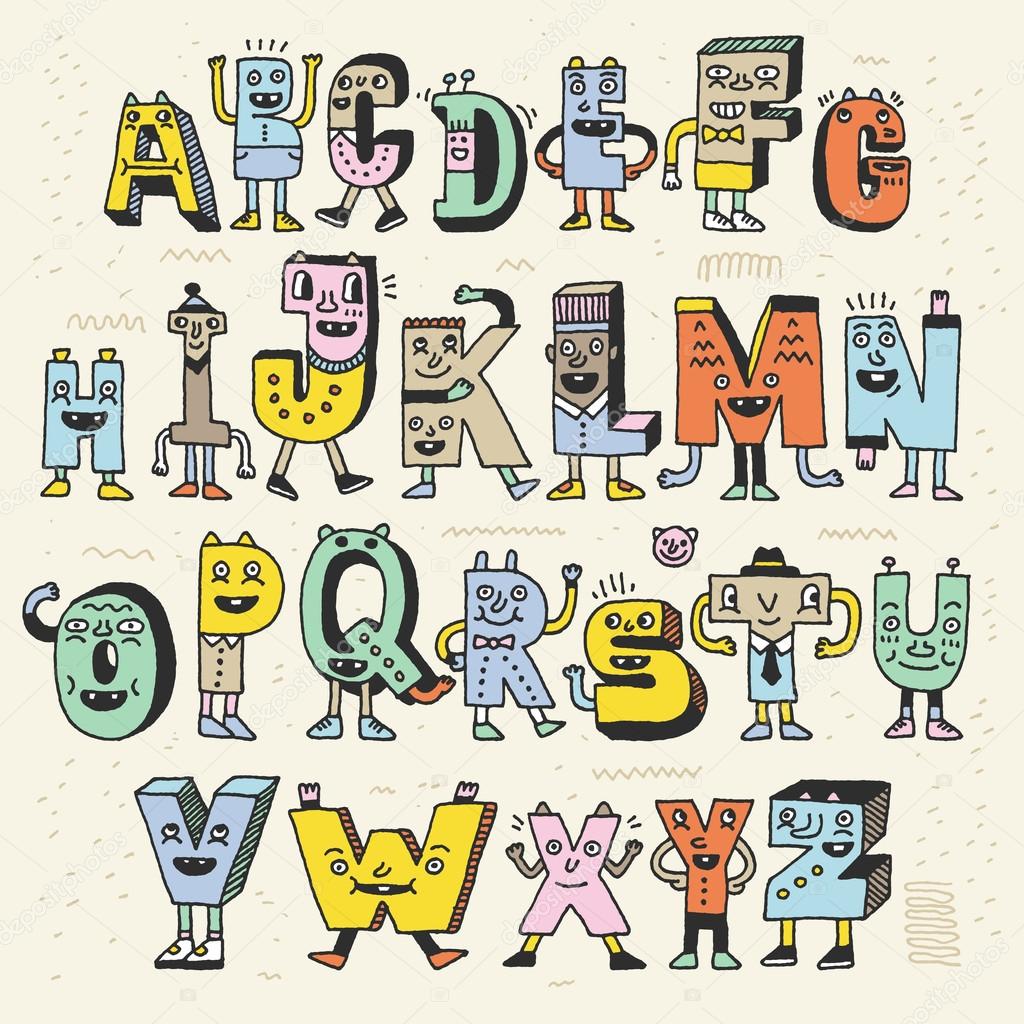Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna.Io sono un cretino che la Madonna non l’ha vista mai.
Tutto consiste in questo, vedere la Madonna o non vederla.
San Giuseppe da Copertino, guardiano di porci, si faceva le ali frequentando la propria maldestrezza e le notti, in preghiera, si guadagnava gli altari della Vergine, a bocca aperta, volando.
I cretini che vedono la Madonna hanno ali improvvise, sanno anche volare e riposare a terra come una piuma. I cretini che la Madonna non la vedono, non hanno le ali, negati al volo eppure volano lo stesso, e invece di posare ricadono come se un tale, avendo i piombi alle caviglie e volendo disfarsene, decide di tagliarsi i piedi e si trascina verso la salvezza, tra lo scherno dei guardiani, fidenti a ragione dell’emorragia imminente che lo fermerà. Ma quelli che vedono non vedono quello che vedono, quelli che volano sono essi stessi il volo. Chi vola non si sa.
Un siffatto miracolo li annienta: più che vedere la Madonna, sono loro la Madonna che vedono. È l’estasi questa paradossale identità demenziale che svuota l’orante del suo soggetto e in cambio lo illude nella oggettivazione di sè, dentro un altro oggetto.
Tutto quanto è diverso, è Dio.
Se vuoi stringere sei tu l’amplesso, quando baci la bocca sei tu.
Se vuoi stringere sei tu l’amplesso, quando baci la bocca sei tu.
Divina è l’illusione. Questo è un santo. Così è di tutti i santi, fondamentalmente impreparati, anzi negati. Gli altari muovono verso di loro, macchinati dall’ebetismo della loro psicosi o da forze telluriche equilibranti – ma questo è escluso -. È così che un santo perde se stesso, tramite l’idiozia incontrollata. Un altare comincia dove finisce la misura. Essere santi è perdere il controllo, rinunciare al peso, e il peso è organizzare la propria dimensione. Dove è passata una strega passerà una fata.
Se a frate Asino avessero regalato una mela metà verde e metà rossa, per metà avvelenata, lui che aveva le mani di burro, l’avrebbe perduta di mano. Lui non poteva perdersi o salvarsi, perché senza intenzione,inetto.
Chi non ha mai pensato alla morte è forse immortale. È così che si vede la Madonna.
Ma i cretini che vedono la Madonna, non la vedono, come due occhi che fissano due occhi attraverso un muro: un miracolo è la trasparenza. Sacramento è questa demenza, perchè una fede accecante li ha sbarrati, questi occhi, ha mutato gli strati – erano di pietra gli strati – li ha mutati in veli. E gli occhi hanno visto la vista. Uno sguardo. O l’uomo è così cieco, oppure Dio è oggettivo.
I cretini che vedono, vedono in una visione se stessi, con le varianti che la fede apporta: se vermi, si rivedono farfalle, se pozzanghere nuvole, se mare cielo. E davanti a questo alter ego si inginocchiano come davanti a Dio. Si confessano a un secondo peccato. Divino è tutto quanto hanno inconsciamente imparato di se. Hanno visto la Madonna. Santi.
I cretini che non hanno visto la madonna, hanno orrore di sè, cercano altrove, nel prossimo, nelle donne – in convenevoli del quotidiano fatti preghiere – e questo porta a miriadi di altari. Passionisti della comunicativa, non portano Dio agli altri per ricavare se stessi, ma se stessi agli altri per ricavare Dio. L’umiltà è conditio prima.
I nostri contemporanei sono stupidi, ma prostrarsi ai piedi dei più stupidi di essi significa pregare. Si prega così oggi. Come sempre. Frequentare i più dotati non vuol dire accostarsi all’assoluto comunque. Essere più gentile dei gentili. Essere finalmente il più cretino.
Religione è una parola antica.
Al momento chiamiamola educazione.