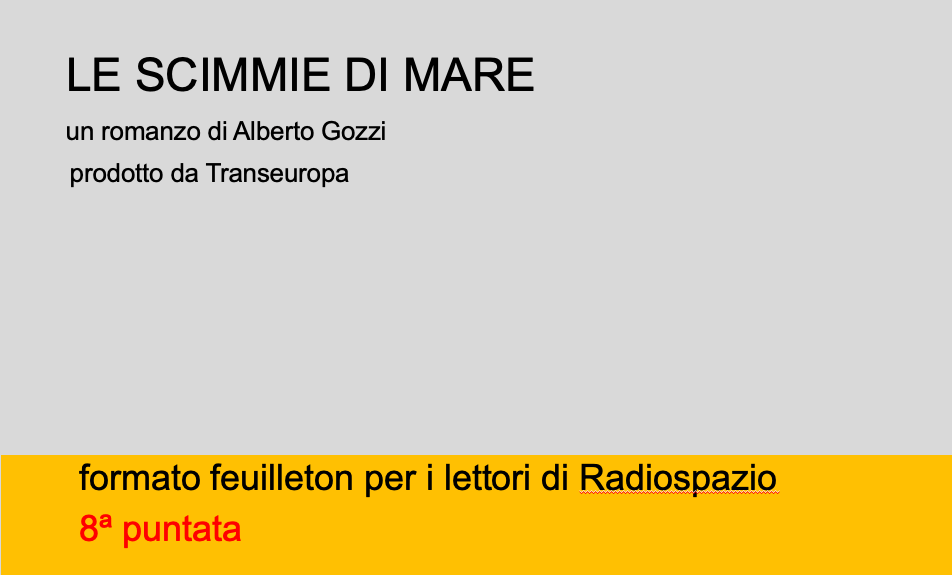
Capitolo ottavo
Che è poco più di un elenco di nomi.
Le anime volarono via dai loro corpi
– volarono alla beatitudine o alla dannazione;
e ogni anima mi passò accanto sibilando.
Coleridge, La ballata del vecchio marinaio
Nessuno sa con esattezza chi è, anche se ci pensa tutte le mattine. A maggior ragione non lo sapevano quegli anni così superficiali. Certo non pensavano che un giorno sarebbero diventati oggetto di convegni, tesi di laurea, inserti vintage sui rotocalchi; non potevano immaginare che le televisioni, tanti anni dopo, avrebbero setacciato gli ospizi alla ricerca di qualche testimone dei “mitici Sessanta” per restaurarlo e mandarlo a spegnersi nell’ultimo show fra le braccia di una conduttrice.
Io dico anni, in realtà sto parlando di uno in particolare. Oggi, tutti lo chiamano 1962, ma è una convenzione
Si dice 1962 e si crede di aver detto tutto. Quelle quattro cifre, apparentemente così semplici, erano solo una facciata dietro cui si intrecciavano eventi che facevamo fatica a collegare al nostro quotidiano. Eventi lontani e vicini. Il New Deal di Kennedy e il primo happening alla galleria de’ Foscherari; la morte di Mattei e il matrimonio a sorpresa della Dida Masetti, non ancora diciassettenne, con uno sconosciuto che l’aveva messa incinta al primo colpo.
In quel tempo, il mondo era smisurato e pochissimo esplorato; gli eventi giungevano a noi da un oceano farraginoso affiorando solo in parte. Non avevamo nessuna voglia di tuffarci in quelle acque dalla profondità incerta, preferivamo analizzare quello che ci riguardava molto più da vicino – la Dida Masetti, per esempio, e il Teatro Stabile, due istituzioni dai destini opposti: la prima era capitolata per mano di un avventuriero misterioso proprio mentre nasceva la seconda istituzione ad opera di una potenza estranea e imperialista che certamente ci avrebbe eliminati.
Le riunioni nelle salette si diradarono spontaneamente fino a che non spirarono del tutto con la naturalezza di chi muore nel sonno.
Quando i drammaturghi si incontravano, ormai solo per caso, alludevano vagamente a una stagione comune, ma molto lontana e malinconica come quelle trascorse al mare, da bambini, quando l’agosto poteva sconfinare serenamente nel settembre perché la scuola era ancora lontana.
I drammaturghi passavano la maggior parte del tempo chiusi in casa a fare congetture sul loro futuro, tentando, per quanto possibile, di prevederlo e di esorcizzarlo.
Giuseppe Bardi. Scriveva atti unici di un anticlericalismo tormentato.
Sposò una ragazza troppo vivace per lui, che morì in giovane età lasciandogli due figli. Schiacciato dal lutto e dalle responsabilità, Bardi cercò riparo nella fede e nella politica. Divenne consigliere comunale della Democrazia Cristiana, corrente Donat-Cattin.
Piergiorgio Sani. Antropologo culturale, il teatro lo interessava solo come strumento di divulgazione. Soggiornò per due anni negli Stati Uniti dove entrò in contatto con alcuni esponenti dei Black Panthers e incominciò a scrivere delle brevi pièce politiche. Durante la pubblica lettura di un suo testo, un attivista nero gli gridò che i bianchi progressisti come lui facevano cagare più di quelli del Ku Klux Klan. Tornato a Bologna, divenne un barone universitario fra i più inflessibili.
Gianni Bergamini. Fra i drammaturghi delle salette era il più marxista. Il suo dramma “Vita e morte del ribelle Barbanera” incominciava con l’entrata in scena di un capo partigiano ferito. “Cazzo!”, esordiva, “Valeva la pena di farsi ammazzare per finire insieme a questi merdosi?” (I fascisti che all’ultimo momento erano saltati sul carro dei liberatori) “Ma io ci piscio sopra!” Deponeva il mitra, voltava le spalle al pubblico, si sbottonava la patta e urinava su un muretto che doveva rappresentare l’abside di una chiesa.
Il Partito storse il naso. La linea togliattiana era chiara; con la Chiesa bisognava andarci piano: via libera alle polemiche con le alte gerarchie cattoliche, ma attenzione alla sensibilità delle masse cattoliche. Bergamini era ligio alla disciplina di partito, e dopo un serrato dibattito accettò di sostituire l’abside con un cespuglio rimediato all’ultimo momento. Anche se così, recriminava l’autore, la scena perdeva molto del suo impatto.
Morì prima di vedere la sua unica nipote, Tatiana Bergamini, eletta Miss Padania-Emilia Romagna, e poi deputata nella Lega di Salvini.
Pierino Delcolle. Era fissato con l’Opera di Pechino. Dopo aver visto La destituzione di Hai Rui aveva ripudiato tutto il teatro occidentale.
Lo incontrai un anno dopo che si era sciolto il gruppo dei drammaturghi. Lavorava per l’ufficio stampa del PSDI. “Visto che non si può fare la rivoluzione”, filosofeggiò, “tanto vale pararsi il culo.”
Mi confidò di aver sposato una donna molto più alta di lui ma di essersi pentito perché la casa era troppo piccola per tutti e due.
Ornella Lanfranchi. L’unica donna che frequentava saltuariamente il gruppo. Pittrice, aveva realizzato per noi qualche scenografia, sempre bestemmiando per la mancanza di soldi. Di famiglia facoltosa, poteva permettersi lunghi soggiorni a Parigi dove frequentava Novella Parigini. Una notte, la famosa pittrice le aveva mostrato, in estrema confidenza, alcuni scritti autografi di D’Annunzio da lei gelosamente custoditi. Ornella, insonnolita, disse che non gliene fregava un cazzo. Di qui, la rottura con la Novella e il ritorno a Bologna.
Raimondo Toscani Dell’Orto. Evitavamo di coinvolgerlo nelle nostre pubbliche letture perché plagiava le commedie di Aldo De Benedetti. Il rischio di sputtanamento era alto. Cercavamo di spiegargli che quella roba non c’entrava niente con la sperimentazione. Lui sorrideva senza ascoltare e sproloquiava di un teatro “leggero come lo champagne”. Gli piacevano quelle signore sinuose, fintamente ingenue, e quegli uomini di mondo che cadevano nelle trappole amorose come dei liceali. “Bisogna capire”, ripeteva, “sotto una superficie frivola, in quel teatro degli anni Trenta c’era un mondo pieno di valori.”
Gli sembrava una riflessione critica importante e si riprometteva di scriverne un saggio. “Ecco, sì…”, dicevamo noi, “è un’ottima idea”.
Si proclamava monarchico per ragioni di famiglia – ma liberale, precisava. Il craxismo gli fece scoprire di essere anche socialista e quando il PSI s’impadronì del teatro italiano divenne un manager itinerante. Non c’era regione in cui Raimondo Toscani Dell’Orto non fosse appena stato (o fosse sul punto di diventare) condirettore di un Teatro Stabile.
La rai gli commissionò la sceneggiatura per un documentario su Garibaldi.
Mario Arduini. Non si sa come, divenne amante di una primadonna in ascesa che scatenò un putiferio per farlo debuttare nella regia. Ma il regista non valeva nemmeno un quarto dell’amante, e la primadonna in ascesa gli saltò agli occhi fin dalle prime prove stroncando una carriera incerta e una passione che poteva durare ancora qualche mese.
Santo Musumeci. Ogni scenografia gli sembrava uno sfarzo scenico che lo mandava in bestia. “Cosa cazzo mi rappresentano tutti quei mobili? Siamo mica nel negozio di un antiquario! E quegli alberi dietro le vetrate? Me ne fotto se sono i ciliegi della minchia di Cechov, non servono!” “Datemi due riflettori, un praticabile e un attore”, minacciava, “ve lo faccio vedere io il grande teatro!” “Brecht!”, concludeva, come un imperativo e un anatema. Il tempo lo rabbonì. Si dedicò al teatro per l’infanzia. Le madri lo guardavano con sospetto, ma i bambini ridevano molto.
Flavio Manunza. Essendo poeta, si sentiva in dovere di scrivere teatro in versi. Noi tentavamo di dissuaderlo. “Non se ne parla”, rispondeva, ” è una questione di coerenza.” Quando uscì il teatro completo di Mario Luzi, smise e non pubblicò nemmeno la sua annuale raccolta di poesie.
Aldo (“Dado”) Fantinel. Compilava drammi storici ambientati a Bologna documentandosi per mesi in biblioteca. Per puro caso, vide uno spettacolo del Living theater, credo fosse Mysteries. La violenza che si sprigionava da quei corpi silenziosi lo aveva lasciato tramortito, al punto che era rimasto seduto da solo nella piccola platea quando tutto il pubblico era sfollato. Dopo molto tempo – così gli parve – si stropicciò gli occhi come uscendo da un sogno e si trovò di fronte Julian Beck che lo guardava incuriosito e gli chiedeva: «E tu cosa ci fai qui?.» Il turbamento fu tale che Fantinel non ricorda il seguito; probabilmente rispose qualcosa come: «Non so… io voglio soltanto seguire te, maestro.» Scomparve per anni. Di lui giungevano rare notizie. Si diceva che peregrinasse insieme alla tribù del Living con il compito di gestire le sostanze, visto che aveva una laurea in medicina.
Capitolo nono
Nel quale si cerca di far passare molti anni riempiendo il minor numero possibile di pagine.
Ha quattro torri e quattro fianchi intorno,
quattro torri custodi e quattro porte,
e piantata nel mezzo ha un’altra torre,
che vien di cinque il numero a comporre.
Giovambattista Marino, Adone, Canto II
Me n’ero andato. Definitivamente. Dopo qualche ricerca avevo trovato un approdo. Non era la spiaggia che sognavo, ma con una certa buona volontà potevo illudermi che le somigliasse; soprattutto soddisfaceva la mia esigenza di allora, essere pagato per ciò che scrivevo. La parola, così immateriale in teatro, si poteva pesare come lo zucchero o il filetto, e valutare secondo le tabelle della Società Italiana degli Autori ed Editori. Un tanto a pagina, al chilo, al minuto.
All’inizio mi avevano messo nell’ammezzato della prima torre, che era riservato agli sceneggiati televisivi del pomeriggio (quelli serali si trovavano al settimo piano della medesima torre). Nel microcosmo dei programmi pomeridiani c’era di tutto. Soprattutto bambini. Bambini ideali così come se li figuravano i dirigenti della Grande Azienda chiusi nella prima torre. Bambini desiderosi di diventare bravi cittadini. Bambini consapevoli che la scuola non può insegnare tutto e che dopo i compiti dovevano correre al televisore per apprendere sempre di più. Oltre ai piccoli, c’erano anche adulti, smarriti nelle nebbie delle cataratte e della vita, che prendevano tutto per buono, cioè per contemporaneo, fresco di giornata, anche gli sceneggiati sulla Repubblica Serenissima di Venezia. Il giorno dopo le trasmissioni scrivevano all’Azienda; erano addolorati per il destino del Doge che se n’era dovuto andare come un ladro e maledicevano i francesi.
Ogni tanto venivo convocato nella prima torre da un dirigente che voleva conversare con me sulla filosofia delle trasmissioni passate e future. Rispetto alle povere cose di cui si parlava, il termine filosofia mi sembrava così improprio che per pudore provavo a sostituirlo con “drammaturgia”, ma venivo subito corretto: no, no, intendevano proprio la Filosofia. I dirigenti la consideravano come una dipendente arrendevole, forse anche un po’ scema, che pur di tenersi lo stipendio era disposta ad accoppiarsi con tutto e con tutti: Filosofia della rete, Filosofia dei palinsesti, Filosofia dell’organigramma, Filosofia della mensa, Filosofia delle bacheche, Filosofia dei contratti, Filosofia del servizio di sicurezza, Filosofia della nastroteca, e persino Filosofia della mobilità interna (intesa come manutenzione degli ascensori e delle scale antincendio).
Durante quei colloqui nella prima torre i dirigenti cercavano di illuminarmi sulla Filosofia dello specifico televisivo. A dispetto dell’enunciato, il fondamento teoretico era semplice: il teatro e la televisione sono due cose molto diverse, e secondo loro io odoravo ancora un po’ troppo di teatro; come un pane chiuso nella madia accanto a una testa d’aglio s’impregna di quell’odore penetrante e difficile da mandar via, così nelle mie sceneggiature ristagnava quello stantio che è tipico del palcoscenico. Io ero giovane e avevo tutto il tempo di evolvermi, cioè di far prendere aria ai dialoghi e alle trame, ma se mi sbrigavo era meglio.
A parte la prima torre, che sorgeva isolata nel mezzo di un piazzale, le altre tre comunicavano fra loro tramite camminamenti coperti. Io ci passavo spesso perché le produzioni che mi venivano affidate erano le più varie e ognuna aveva una collocazione diversa: gli sceneggiati radiofonici originali, torre 2, secondo piano; la rielaborazione di opere letterarie edite, torre 3, quarto piano, e così via. Ogni settore dipendeva da un funzionario con cui dovevo intrattenermi prima di iniziare i lavori: non solo sulla Filosofia delle trasmissioni, ma su loro stessi, sulla loro storia nell’Azienda, sul loro passato e sulla loro vita in generale, dentro e fuori quelle mura.
Uno collezionava rane di ogni genere e formato. La scrivania ne era invasa. Reminiscenze dei suoi studi pascoliani: “Nei campi c’è un breve gre gre di ranelle…”, mormorava, poi recitava per intero “La mia sera”, perché, oltre che italianista era stato anche un attore, anzi un fine dicitore.
Uno aveva cenato con Luca Ronconi.
Uno credeva di essere la reincarnazione di Joseph Conrad. Assomigliava a Clark Kent. Era molto ammirato dalle donne. “Grazie”, diceva, “ma preferisco il mare.”
Uno tirava qualche boccata di tabacco Dunhill da una pipetta del XIX secolo che teneva in bella vista sul tavolo. A cinquant’anni si era dedicato allo studio della lingua inglese, quindi aveva tradotto The Giaour, di Byron (“Un’illuminazione!”) riuscendo anche a farlo pubblicare da un editore di Bari (non Laterza). Quell’esperienza lo aveva rivitalizzato, come succede a certi vegliardi che fanno un figlio con una venticinquenne.
Uno era amico del gastronomo Veronelli con cui disquisiva di cucina e letteratura. Citava spesso Gadda e il risotto. Sua moglie non era avvenente, non lo era mai stata nemmeno da giovane, mi aveva confidato (chissà perché). Però era dolcissima, e per amore era diventata una cuoca appassionata e frenetica. Una sera, mentre lui rincasava dall’ufficio sotto una pioggerella di quelle che fanno pensare, si era imbattuto in una venditrice di violette e subito gli era venuta in mente la devozione della sua sposa che in quel momento gli stava preparando la cena. Da quanto tempo non le portava un fiore?
Quante volte l’aveva tradita, sia pure solo mentalmente, con le attrici che sfilavano nel suo ufficio in cerca di scritture? (Una notte, per la verità, si era verificato anche l’atto carnale vero e proprio, ma non contava perché l’attrice, ubriaca, aveva vomitato nel letto. Lo schifo e l’imbarazzo con l’albergatore, la mattina seguente, erano stati un’abbondante espiazione).
Eccolo dunque mentre apre la porta di casa con un sorriso da fidanzato e il mazzolino timido in mano. La moglie vede le violette e s’illumina: «Che pensiero squisito!» – è proprio un grido che le prorompe dal petto. Gli strappa di mano i fiori, corre in cucina, prepara zucchero, tegame e manuale «Le faremo candite!» dice, «Yum Yum…!»
Uno aveva sposato Miria Canelli, che era stata Miss Italia nel 1955 e subito aveva preso la brutta china del fotoromanzo. Ma dopo il matrimonio ci aveva pensato lui a sistemare le cose piazzandola alla radio come annunciatrice, un posto tranquillo e ben protetto – non poteva mica passare la vita a rincorrerla da un set all’altro! L’immagine della moglie che si baciav con uno di quegli idioti di Grand Hotel o di Bolero film lo rabbuiava, e lì terminava il nostro colloquio.
Le vite dei funzionari, tutte così rivolte al passato, si infiltravano giorno dopo giorno nella mia vita come rigagnoli, e le nostre vite, sempre più intrecciate le une con le altre, confluivano nelle vene di quell’organismo tanto più grande di noi che era l’Azienda, e il nostro pensiero e il pensiero dell’Azienda erano della medesima sostanza così come lo sono l’aria e i gabbiani, dei quali essa regge i fili mentre volteggiano e fanno i matti credendosi i padroni dello spazio.
Quando transitavano nel complesso delle torri, gli anni rallentavano, il loro tasso di acidità aumentava e corrodeva velocemente la pellicola che protegge le identità dei singoli.
Osservavo gli altri autori (eravamo in tanti). Tutti si andavano somigliando sempre di più; mi avvicinavo a un crocchio (non si muovevano mai da soli) e sentivo un’unica voce moltiplicata per otto o per dieci. Questo fenomeno era più evidente negli autori della quarta torre, quella del Varietà, presso la quale venni distaccato per qualche tempo.
All’inizio cercai di oppormi:
– Sarebbe un cattivo affare per l’Azienda e per me; il Varietà è la cosa più lontana dalla mia sensibilità.
– Qui non ci sono sensibilità, qui si tratta di mestiere. 52
– Appunto, questo mestiere non lo so proprio fare.
– Stronzate. Tutto s’impara.
– Ma perché dovrei impararlo proprio io? Ci sono centinaia di aspiranti autori che sognano di passare la vita inventando quiz a premi, siparietti, sketch e parodie di canzoni.
Il dirigente era di quelli che non si spazientiscono. Nella sua lunga carriera aveva tenuto anche dei master sulla Filosofia dell’autorialità giovanile. Sollevò la sua mole importante dalla scrivania:
– Usciamo, facciamo due passi. Si metta il cappotto.
Il piazzale in cui sorgeva la quinta torre era immerso in un pulviscolo acquoso di novembre.
– Ha un berretto?
– Credo di sì – in tasca tenevo un kangol che non usavo mai perché mi dava un’aria poco intelligente.
– Meglio che lo metta. È umido, qui.
Si preoccupava per me. Aveva indossato un cappello di tela cerata blu col sottogola, di quelli da baleniere. Guardava il cielo, indeciso se incamminarci in senso orario o antiorario.
Infine ci muovemmo. Sentivo che non sarebbe stato un viaggio breve.
Compimmo alcune circumnavigazioni della torre. Il dirigente non aveva fretta; a casa non lo aspettava nessuno, mi confidò: la moglie se n’era andata da una decina d’anni, quando era rimasta incinta di un funzionario di seconda fascia da cui avrebbe poi avuto due figli: «Era un uomo di scarse ambizioni. L’ideale per una donna come quella. Nessun rancore.» Sembrava sollevato che lei avesse fatto i figli con quell’altro.
Quando i fari accesero le loro luci gialle e incominciarono a perlustrare il piazzale avanti e indietro, il dirigente entrò in argomento: la mia resistenza al Varietà lo aveva stupito, più che deluso – ero giovane, ma avevo già una certa esperienza alle spalle, non come le reclute dei corsi sulla Comunicazione che si riempiono la bocca con la drammaturgia, i generi, le scritture… Puttanate buone solo per i seminari e i convegni… per carità, mica diceva di sopprimerli… anche i teorici, i critici, gli autori autoriali, povere anime, avevano diritto di vivere…
Si era fermato e aveva sollevato l’ala anteriore del casco baleniero per guardarmi in faccia:
– … Ma l’Azienda non è una nursery, né un parco giochi. E neppure una provincia dell’Arcadia. Qual è l’ultima trasmissione che ha fatto?
– Il pipistrello rosa, un cabaret letterario. 53
– Titolo del cazzo.
– Alla Direzione generale è piaciuto.
– Lasciamo stare. Programmazione serale, immagino.
– Sì, da luglio a settembre, alle ventuno.
– Programmazione serale, estiva e culturale. A lei piace stare nel bagnasciuga del palinsesto, là dove sguazzano le signore sole e gli insegnanti zitelli.
– Non conosco bene il pubblico di quella fascia oraria…
– Lo conosco io. Ascoltatori desiderosi di accedere alla cultura in pillole che assumono prima di coricarsi. Per tre mesi lei è stato il loro farmacista di fiducia. Le avranno scritto molte lettere, immagino…
– Qualcuna…
– … Lettere piene di gratitudine per un programma intelligente e istruttivo, finalmente degno di un’emittente pubblica e altre ruffianate del genere.
– Anche fosse se così …
– È così, non faccia il furbo! Lo so perché alla sua età ho trafficato anch’io con la cultura. Guardi che non le rimprovero niente, è un lavoro sporco e qualcuno deve pur farlo. Bisogna averci lo stomaco.
Si era fermato di nuovo, questa volta sotto un riflettore. La luce gialla lo trasformava in un vecchio Commendatore dalle orbite vuote.
– Mi correggo, più che sporco è un lavoro mistificatorio. Quelle pillole radiofoniche sono innocui diuretici rivestiti da una pellicola di cheratina culturale; di notte, gli ascoltatori si svegliano un paio di volte e pisciano via tutto. Niente contro i diuretici, ma bisogna chiamare le cose col loro nome.
Quasi tutti i dirigenti che avevo conosciuto erano fragili e corrosi da un furore autolesionista, Irridevano il mondo accademico e un attimo dopo piangevano sulle brillanti carriere universitarie che avrebbero compiuto se non si fossero lasciati accecare dal mito della comunicazione di massa e dall’Azienda. Il furore di questo dirigente non assomigliava a quello degli altri, era freddo, pragmatico, e mirava a un solo scopo: perfezionare la macchina già micidiale del Varietà con l’ostinazione dello scienziato che, dopo avere scoperto il gas nervino, prosegue gli esperimenti per potenziarlo ancora in attesa di trovare un’altra sostanza più letale.
– Non sono un ingenuo, sa? È chiaro che per lei il Varietà è la merda.
– Non l’ho detto.
– Non faccia l’ipocrita, lo penso anch’io, ma questo non conta. Per l’Azienda è un prodotto importante, sicuro; il pubblico lo percepisce come genuino, senza secondi fini, altro che la divulgazione culturale! L’immediatezza del Varietà o, come dice lei, della merda, riconduce gli ascoltatori alla spontaneità dell’evacuazione, che è un atto di gioia, almeno durante l’infanzia, perché poi con gli anni le cose si complicano…
Tacque. Completammo il giro intorno alla torre.
– Veniamo al punto. Quelli della Direzione Generale hanno fatto una delle loro pensate: i programmi di Varietà devono essere ammodernati. Come, non lo dicono perché non lo sanno nemmeno loro. Inutile farli ragionare, non ti ascoltano, è come un raptus. Alzano il telefono e abbaiano “Rinnovare, rinfrescare, ammodernare! Da domani!” Dopo un quarto d’ora se ne sono già dimenticati, ma la rogna rimane e dobbiamo risolverla noi. Secondo me è una stupidaggine. La merda va servita nella sua versione base, come la pizza. Non so lei, ma quando vedo quei menù che non finiscono mai… alla Wagner, ai würstel con pere williams, alla Gay Pride, alla Peppe, al cacciucco, mi si chiude lo stomaco. Comunque è inutile contarcela fra noi, quelli si aspettano che facciamo qualcosa, almeno pro forma, almeno come alibi
L’alibi dovevo essere io. C’era, nelle mie trasmissioni, in tutte, di qualunque genere, qualcosa di irrisolto. Reticenza congenita, pudore, – forse anche un po’ di snobismo che inserito in piccole dosi nei copioni del Varietà poteva funzionare come correttivo. La Direzione generale, ammetteva il mio stratega, non aveva tutti i torti: le trasmissioni stavano sbracando troppo, e la mia sola presenza nel team degli autori sarebbe stata raggelante. Certo non avrebbero accolto a braccia aperte, ma qualcuno doveva sacrificarsi. Questa volta era toccato a me. Oltre alle buone ragioni dell’Azienda, ce n’era un’altra, decisiva, che si era tenuta per ultima:
– Lo sappiamo tutti e due: lei non è abbastanza ricco per dire di no.
Abbiamo grandi aspettative su di lei. Confido che farà la scelta giusta.
“Quiz Show”, regia di Robert Redford 55
La mia permanenza nello stanzone del Varietà fu meno difficile di quanto temevo. Mi avevano messo in una scrivania isolata, lontana dal grande tavolo su cui gli autori lanciavano pagine e pagine che andavano a formare una montagna disordinata di carta; poi, quando suonava il mezzogiorno, tutti insieme si strappavano di mano i fogli come al rubamazzo e li ricomponevano in un numero imprecisato di copioni.
Ogni tanto mormoravo qualche riflessione sul comico citando Pirandello, Musil, Alberto Sordi, oppure improvvisavo. I miei nuovi colleghi smettevano per un attimo di rovistare fra i copioni, annuivano e subito riprendevano perché dovevano consegnare prima della mensa.
Una convivenza serena, tutto sommato.
Gli autori del Varietà erano posseduti da un’allegria distruttiva, come la vittima di “Scarpette rosse” che dopo aver indossato le calzature diaboliche è trascinata in una danza sempre più frenetica culminante nella perdizione.
Il Demone dell’allegria infuriava dentro quei corpi spenti. In ascensore, in mensa, al bar, la banda del Varietà si annunciava con uno sciame di battute che innescavano le risate, e le risate sovrastavano le battute, e passavano le settimane e i mesi.
La turbina che ruotava nei loro corpi giorno e notte li condannava a un invecchiamento precoce, così come il sole africano delle Eolie cuoce i volti degli isolani trasformando gli adolescenti in arrostiscini rinsecchiti e le giovani madri in vecchi copertoni di camion.
Questo processo risultava più evidente nelle donne.
La Regina del Varietà, un’autrice che per l’anagrafe era giovane e fresca come un bocciolo, assomigliava a una foto di Liala settantenne che mostra la prima copia del suo libro “Di ricordi si muore”.
In quel viso di cartapecora venticinquenne si muovevano solo gli occhi, piccoli e incattiviti; la Regina era consapevole di aver consumato la giovinezza nei lavori forzati dell’allegria, e il suo trono non le bastava più; ora pretendeva un risarcimento importante, proporzionato alla pena cui si era condannata da sola.
Il suo tormento era diventato una fotografia di Liala settantenne.
Un giorno se l’era trovata sulla scrivania. Certamente l’aveva messa lì qualche collega maligno e lei l’aveva conservata senza sapere il perché, così come si coltivano certi fiori velenosi.
Quell’immagine era diventata un cruccio da cui non poteva separarsi. Ogni tanto fermava il lavoro delle dita che crivellavano i copioni di battute comiche e interrogava il ritratto, come fanno le bimbe con le nonne, sul suo successo e sui suoi amori.
Liala, almeno in fotografia, era tutto il contrario di una nonna sdolcinata, parlava schietto:
– Vuoi sapere del successo? Bene, incominciamo dalla nascita. Sicuramente essere di nobile lignaggio può servire. Tu, da che famiglia provieni?
–…
– Ho capito, lasciamo perdere. Punto secondo: anche gli uomini possono contare, non per quello che ti danno – più o meno è sempre la stessa musica – ma perché fanno curriculum. Per me, il matrimonio fu un buon avvio. Pompeo Cambiasi, marchese e ufficiale di marina. Io un fiore, lui piuttosto stagionato. Il naufragio coniugale era scritto prima delle nozze, infatti nell’entourage se ne parlò molto, il pubblico ama ciò che è del tutto prevedibile. Ottenne un buon successo anche la mia relazione con Vittorio Centurione Scotto, un altro marchese e con un nome che suonava bene. Quando morì tragicamente, la mia popolarità salì di parecchio – e pensare che non avevo ancora scritto niente. Il mio strazio fu la mia fortuna.
Il pubblico mi amò ancor prima di leggere il mio primo libro. Giovane, bella, con un marito disperso e amputata di un amante ancora fresco… Tu come sei messa con gli uomini?”
–…
Più la Regina del Varietà approfondiva la conoscenza di Liala, più la Signora del romanzo rosa le appariva come un purosangue che galoppava irraggiungibile. Quegli amori, quei marchesi, quei lignaggi erano barriere troppo alte per i suoi garretti, buoni tutt’al più per il trotto o per il dressage. Ma nel racconto di Liala c’era una frase che le sembrava un piccolo scoglio cui aggrapparsi: “Il mio strazio fu la mia fortuna”.
Un pomeriggio, la Regina del Varietà si stava arrabattando inutilmente sulla battuta conclusiva di uno sketch che doveva introdurre il Domandone finale del Quizzone. Tutte le battute comiche provocano un tormento fisico e morale in chi le scrive, soprattutto le battute comiche che preludono al Domandone finale.
Quel pomeriggio passavano le ore e la battuta non voleva venire.
Allora, finalmente, la Regina del Varietà pianse. Era la prima volta nella sua giovane vita. Prima di rabbia, poi d’impotenza, poi di paura. Poi fu presa da una sofferenza senza forma e venne avvolta da un boato che le trapanava le orecchie e la mente.
Erano tutte le risate su cui aveva costruito il suo trono.
“Il mio strazio fu la mia fortuna”. Ricordò ancora una volta le parole della sua ispiratrice.
E fu la volta decisiva.
Il giorno dopo diede in appalto la produzione di copioni a un’autrice senza pretese che si accontentò del 15 %, era tanto che aspettava un’occasione come quella!
Divenne scrittrice.
Piacque agli editori il suo personaggio: una bambina appassita che viveva in una grande casa un po’ sgangherata e circondata da un giardino selvatico in compagnia di un cane, due gatti, un leprotto e un’anziana tartaruga parlante (questo il profilo che aveva creato il suo ufficio stampa).
Uno dopo l’altro, i libri della Regina spiccarono il volo dalle tipografie per andarsi a posare con grazia sugli scaffali e nelle vetrine delle librerie – erano libri leggeri ma per niente sprovveduti, mica andavano a infilarsi negli scaffali rasoterra.
Quando ebbe preso possesso della sua nuova vita, la Regina (non più del Varietà) si ricordò dei vecchi compagni e li chiamò a condividere le gioie della Letteratura. All’inizio qualcuno era perplesso: davvero si poteva diventare scrittori così, di punto in bianco? La loro leader li rassicurava, non era difficile, bastava riprendere i vecchi sketch e metterli giù in forma di racconto.
Storie un po’ quotidiane e un po’ surreali.
Un po’ di nonsense e un po’ di satira.
Bambini che strillano nella notte, biberon e separazioni.
Cronache buffe del Premio Strega. Il bidone di Ferragosto. Amanti ma per ridere. Biscotti e bambocci. Un levantino misterioso. L’adozione di Turlurù. Falsi allarmi di menopausa. Il maschio incapace e la femmina verace. Il bodybuilding del collega introverso. Nostalgie agrodolci. Un tè con Jorge Amado. La rissa delle marmellate. L’amica pornostar.
In quegli anni si stavano riscoprendo le risorse del riciclaggio. Film famosi venivano convertiti in spettacoli teatrali, i quali, opportunamente rielaborati, diventavano a loro volta romanzi che generavano altri film, e così via.
Anche la banda del Varietà ci si mise d’impegno. Nacquero così libri e libriccini di ricette travestite da storie d’amore, di cronache matrimoniali in forma di abbecedario, di diari intimi da leggere ad alta voce come scioglilingua.
Una sera, riconobbi uno di questi testi nati per il Varietà. Si era trasformato in copione teatrale. Gli avevano cambiato il titolo e lo avevano truccato con un paio di baffi e una parrucca brizzolata. A uno spettatore che ignorasse la sua origine poteva sembrare un copione come tanti altri.
I copioni come tanti altri si andavano moltiplicando. Ne trovavo dappertutto. Nei garage teatrali che ammiccavano a quelli degli anni Settanta. Nei teatri a gestione familiare capocomicale. Nelle rassegne giovanili.
In certi stati d’animo quasi soprannaturali, la profondità della vita si rivela interamente nello spettacolo, per quanto banale, di ciò che abbiamo sotto gli occhi. Ne diviene il Simbolo.
Baudelaire, Fuochi d’artificio
Un pomeriggio, decisi di scendere in quella che era diventata una piccola discarica dei miei copioni e che un tempo avevo definito con enfasi adolescente “il magazzino delle parole”. Non lo chiamavo più così. Non lo chiamavo in nessun modo. Evitavo anche di pensarci, oppure lo pensavo come un là sotto che un giorno sarebbe stato venduto insieme alla casa. Nel contratto lo avrebbero definito cantina, perché là sotto non sarebbe piaciuto al notaio.
La discesa non fu semplice. Avevo perso la chiave. Mi succede sempre con certe chiavi che aprono certe porte. Occorreva un fabbro, come ogni volta che dovevo andare nel là sotto: un fabbro e una chiave nuova. Ma in tutti quegli anni il vecchio fabbro era morto, me lo comunicò la moglie al telefono, stupita – ero l’unico che si ricordava di suo marito.
Ne fui sollevato e rinunciai volentieri.
Invece qualcuno, troppo solerte, mi diede il telefono di un fabbro vivo.
Il fastidio dell’appuntamento. Lo scetticismo del fabbro nuovo di fronte alla serratura corrosa («Ma quanto tempo è che non entra qui dentro?»). La delusione dello stesso fabbro, una volta forzata la porta, nel vedere quei mucchi disordinati di carte («Tenere impegnato un vano così grande per questa roba è proprio gettare via i soldi.»)
Rimanemmo soli, io e i fogli. Ne scelsi una piccola risma a caso e incominciai a scorrerli appena in superficie.
Me lo sentivo.
Anche i miei erano diventati copioni come tanti altri. Come tutti gli altri. Quelli che avevo scritto, quelli che avevo letto, quelli che non avevo letto e anche quelli che non avrei mai potuto leggere perché se ne stavano sepolti nei cimiteri della Società autori, quelli appassiti insieme alle rose nei cassetti dei commediografi di provincia, quelli addormentati nei pensieri degli autori ancora bambini che sedevano sui banchi delle elementari senza sapere che di lì a qualche anno avrebbero incominciato a scrivere, senza ragione, degli atti unici per il teatrino della scuola – qualche insegnante di Lettere irresponsabile li avrebbe incoraggiati a continuare, li avrebbe seguiti con trepidazione anche dopo il Liceo, e un giorno avrebbe festeggiato con loro una menzione al premio teatrale Hystrio.
Doveva esistere da qualche parte un Copione Padre occulto che si riproduceva incessantemente generando una quantità di copioncini solo apparentemente difformi; cambiavano i titoli ma la sostanza era la medesima, come quella delle piccole tagliatelle che formano l’interminabile nastro della Tenia.
Ricordo lo sfogo di un amico regista, poco prima di suicidarsi:
«È terribile, non sopporto più il rumore degli attori! È come quello del frigorifero, ma molto più forte. Se non ci pensi, non te ne accorgi, ma se ascolti davvero, come sei costretto a fare durante le prove, senti un bru-bru di sottofondo che ti porta alla pazzia.
Recitano Ibsen, Neil Simon, Marivaux?
Non lo sanno e anche tu l’hai dimenticato.
Recitano il loro bru-bru di attori.
Cinque, sei, sette ore di fila. Devo smettere.»
Seduto sul grande tavolo della sala prove, dondolava le gambe nel vuoto e continuava a ripetere “bru-bru, bru-bru, bru-bru”, sempre più stanco, con la faccia di un vecchio asino condannato alla macina.
Due mesi dopo si era tolto di mezzo. La moglie e gli amici dissero che se l’aspettavano perché da qualche tempo vedeva e sentiva cose strane. La solita fretta di archiviare il morto.
L’intuizione del mio amico regista non riguardava soltanto le voci degli attori. Diedi un’occhiata alla discarica delle mie carte e mi resi conto che esisteva anche il bru-bru dei copioni generati dal Copione Padre. Mi sembrava che diventasse sempre più forte. Forse non sarei mai dovuto scendere.
Uscii e chiusi la porta a doppia mandata con la chiave ancora fresca di fabbro. Risalii le scale e la gettai in un cassonetto.
(Continua)
Leggi le puntate precedenti:
1ª puntata https://wordpress.com/post/radiospazioteatro.wordpress.com/23112
2ª puntata https://wordpress.com/post/radiospazioteatro.wordpress.com/23117
3ª puntata https://wordpress.com/post/radiospazioteatro.wordpress.com/23125
4ª puntata https://wordpress.com/post/radiospazioteatro.wordpress.com/23138
5ª puntata https://radiospazioteatro.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=23148&action=edit&calypsoify=1&block-editor=1&frame-nonce=22422974b9&origin=https%3A%2F%2Fwordpress.com&environment-id=production&support_user&_support_token
6ª puntata https://wordpress.com/post/radiospazioteatro.wordpress.com/23156
7ª puntata https://wordpress.com/post/radiospazioteatro.wordpress.com/23169
