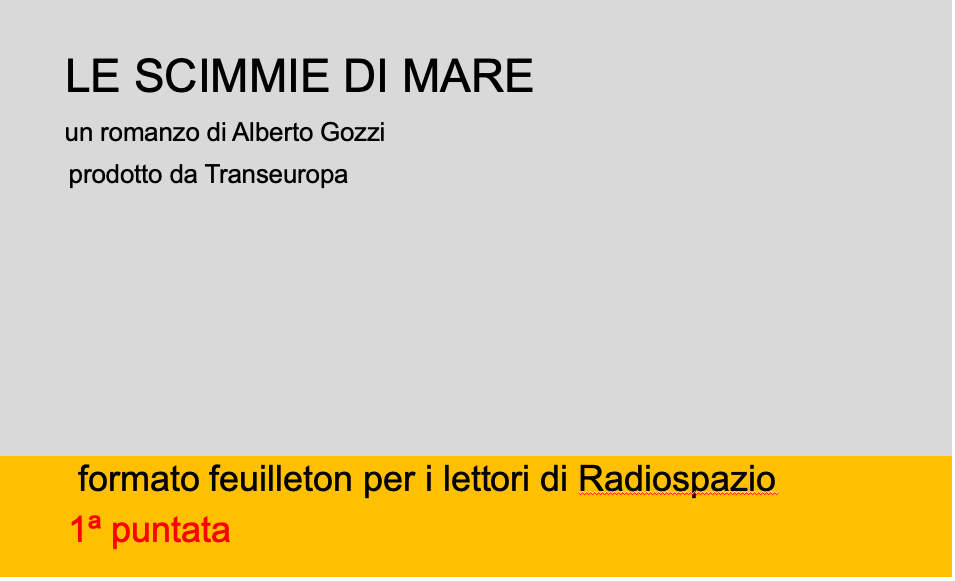
Prima parte
Capitolo primo
Nel quale si deve ritornare indietro per segnare un punto d’inizio.
Riguardo alla trama trovo del tutto inutile la vita reale. La vita reale sembra non avere trame. E poiché una trama è desiderabile e quasi necessaria, ho questo cruccio ulteriore contro la vita.
Ivy Compton Burnett, Tè e Tao
Quasi tutto era andato. Una decina di righe potevano bastare per ricomporre ciò che era rimasto. Di parole ne erano avanzate poche. Ciascuna se ne stava per i fatti suoi, quando si incontravano non si salutavano neanche più.
Scendevo sempre meno volentieri nel magazzino delle parole; ogni volta dovevo constatare che ne mancavano sempre di nuove, anche se non ero in grado di dire quali, così prendevo uno sgabello e mi sedevo a guardare gli scaffali cercando di ricostruire i vuoti. Ma quasi subito mi distraevo e invece di fare l’inventario pensavo a quando, molti anni prima, ero stato il titolare di un’impresina individuale che produceva parole per il teatro. Funzionava. A quell’epoca c’erano altri piccoli produttori come me e tutti più o meno tiravano avanti, anche perché allora il processo di lavorazione delle parole era più semplice – più disinvolto, direi, come quegli anni che procedevano al trotto.
Le parole per il teatro si generavano e si combinavano grazie a una forza interna sulla quale non stavamo tanto a indagare, bastava scrivere qualche nome sulla pagina: Finkel, Annabelle e Livermore, per esempio. Chi erano? L’autore non perdeva tempo a chiederselo; circolava la convinzione euforica che i nomi contenessero già tutto; la nostra macchina drammatica era sempre accesa e per avviarla bastava una battuta qualsiasi:
Finkel: – Purtroppo il nostro incontro sarà molto breve. (guarda l’ora) Praticamente sto per ripartire.
Il resto della scena si sarebbe sviluppato da sé, come nella vita, della quale molti pretendevano che il teatro fosse lo specchio.
Io opponevo una resistenza silenziosa. Vista la mia età prematura il concetto di vita mi sembrava vago e inutile; pensavo che semmai si sarebbe precisato molto più avanti, quasi verso la fine, quando non avrei più saputo cosa farmene – devo dire che ancora oggi non mi sembra un chiarimento così necessario. Invece tutti gli altri produttori di parole per la scena ne erano avidi. Di vita e di trame. Le trame della vita. Che non finiva mai di stupirli, sostenevano. I più ingegnosi costruivano sottotrame tortuose, cunicoli che diventavano sempre più bui e nei quali quegli stessi ingegneri finivano per smarrirsi come talpe analfabete.
Qualche drammaturgo forzuto aggrediva le vite con lo scalpello e ne ricavava dei blocchi rudimentali. «Ormai m’interessano soltanto le tranche de vie», diceva con una certa aria snob. Ma sempre di vite si trattava anche se sulla scena viaggiavano scombinate, un pezzo di qua e uno di là – e comunque l’autore si preoccupava sempre di rimetterle sui binari per lo scioglimento finale che il pubblico aspettava sbirciando l’orologio.
Su questo appuntamento obbligato c’era poco da fare i furbi: niente finale, niente applausi, che erano la stagnola dorata delle nostre spagnolesche bottiglie.
Le vite che i miei colleghi drammaturghi scrivevano per il teatro erano quelle di operai in lotta, preti in crisi d’identità, minatori imprigionati nel buio della terra, prostitute indomite, partigiani con il mitra ancora tiepido, borghesi a caccia di lolite proletarie che allora venivano chiamate ragazze perché di Nabokov non si sapeva ancora niente.
Quasi tutte queste povere vite riuscivano a trovare una qualche forma di esistenza; raramente sul palcoscenico, più spesso per voce degli stessi autori che leggevano i loro copioni teatrali riuniti nelle salette più interne delle osterie cittadine. Alla nausea nervosa, tipica delle competizioni, si aggiungeva un piccolo malessere; forse era un embrione di pietà solidale, perché un autore che accetta di recitare la sua operina dattiloscritta davanti a una decina di altri autori è una creatura smarrita e disposta a qualunque bassezza.
Mezzi falsetti di maschi ancora incompleti supplivano alla mancanza di voci femminili. Qualche didascalia tentava di aggiungere profondità alle battute (“Impallidisce improvvisamente”. Come può un attore sbiancare a comando? Non ce lo si chiedeva. La didascalia aggiungeva un che di letterario alla pièce, e tanto bastava).
E l’imbarazzo prima di incominciare: «Devo leggere il nome del personaggio prima di ogni battuta oppure si capisce dall’intonazione?»
E la calce francescana delle piccole osterie si rifletteva su quelle vite dattiloscritte alle quali tentavamo di dare voce.
E dopo quelle performance sembrava che il Teatro fosse sempre più lontano (in città ce n’era solo uno accessibile, gli altri erano in mano alla reazionaria borghesia). Quell’unico teatro del nostro desiderio era tenuto prigioniero nel corpo di un palazzo rosso ottocento del centro città, ben protetto dalle barriere dei burocrati giù nell’atrio:
«Ma questo spettacolo ha qualche attinenza alla classe operaia?»
Gli spettacoli che avevano attinenza venivano dotati di una scenografia molto sobria: tavoli e sedie che sembravano proprio veri, un paravento – giusto per non mostrare gli attori e le attrici in mutande – a volte un catino con treppiede nel quale il protagonista si lavava la faccia dopo una giornata di lavoro e di lotta – e l’acqua (autentica) si mescolava alle lacrime (teatrali) che l’attore virilmente si asciugava.
Gli spettacoli che non avevano attinenza (alla classe operaia) erano catalogati come sperimentali. I burocrati li guardavano con sospetto perché temevano le reazioni dei lavoratori:
«… Sai, bisogna andarci piano… Un povero cristo si rompe la schiena tutto il giorno, rientra in fretta, esce di casa con la moglie, va a teatro e si trova davanti a una cosa del genere…».
Di conseguenza, niente scenografia.
«Già vi diamo la sala per due sere, al resto dovete pensarci voi.»
Refrattario com’ero a mettere in scena trame e vite, i miei copioni finivano d’ufficio fra quelli sperimentali. Insomma, ero stato arruolato senza aver firmato il cartellino, così mi davo da fare per onorare la divisa. Scrivevo operine dai titoli improbabili, come X corpus, o Tutto rosso. I personaggi erano del tutto casuali. Entravano in scena e subito incominciavano a raccontarsi. Non gliene importava niente dei racconti degli altri, toccava allo spettatore ricomporre quei frammenti narrativi, non erano certo fatti miei.
Il Partito Comunista, che qualche volta assisteva seduto in fondo alla sala, taceva. Forse elaborava. Anche gli altri spettatori rimanevano in silenzio ma elaboravano poco, direi, più che altro sospiravano. Brave persone, erano rassegnati ai tempi nuovi, speravano solo che sarebbero passati presto.
Alcuni si sentivano in dovere di venire a salutare dopo lo spettacolo, frastornati, loro e io, come dopo un evento ingombrante e irreparabile – un lutto, ad esempio, ma di un parente lontano che fa un’improvvisata dopo vent’anni e muore stecchito sul divano lasciandoci quel suo corpo fuori luogo da sistemare.
Essere d’avanguardia è conoscere ciò che è morto; essere di retroguardia è amarlo ancora.
Roland Barthes, Risposte
Delle mie scorribande nelle regioni del teatro ero chiamato ogni tanto a rendere conto. Quando il mio maestro Luciano Anceschi veniva a vedere uno spettacolo, il mattino seguente mi convocava per telefono. Mentre lo accompagnavo all’Università poneva domande molto elementari, sorprendenti in un uomo così immerso nella complessità:
«…Ma questo tuo lavoro, in che cosa sarebbe sperimentale?»
Era coerente alla scuola fenomenologica, praticava la sospensione del giudizio e aspettava che parlassi io. Il teatro gli interessava poco, credo che lo considerasse qualcosa di simile a una scampagnata della Letteratura.
Alcuni anni dopo, in ufficetto soffocato dal luglio romano, Giuseppe Bartolucci, critico, teorico e architettore del Nuovo, sospirava:
«Sto lavorando a una mappa teatrale degli anni Settanta… Praticamente avrei finito. Otto mesi di lavoro… ascendenze, contiguità, affinità… Leo e Perla… Ricci… Quartucci, Vasilicò… Li ho sistemati tutti, ma te non so proprio dove metterti, sai?»
Ero imbarazzato. Davvero. Mi dispiaceva turbare una cosmogonia così ben organizzata; tutti quei pianeti avrebbero viaggiato tranquilli nella loro orbita se non fossero inciampati in quel corpo estraneo che ero io – molto estraneo, come una lavatrice o un aspirapolvere proiettati nella galassia dell’avanguardia da un dio distratto: mi aveva fatto dono del dialogo (un po’ sghembo, quindi sperimentale), ma si era dimenticato la teatralità. Di quella proprio non c’era traccia.
“Che cos’è la teatralità? È il teatro meno il testo” – su questo punto, Roland Barthes era chiaro. Di conseguenza io ero fottuto; nei miei copioni c’era soltanto un va e vieni di gente che parlava, anzi che diceva dei testi scritti; naturalmente avevano anche un corpo, ma per me era un accessorio secondario così come le scene e i costumi.
Se mi otturavano il rubinetto delle parole, tanto valeva che chiudessi subito bottega.
(Continua)
